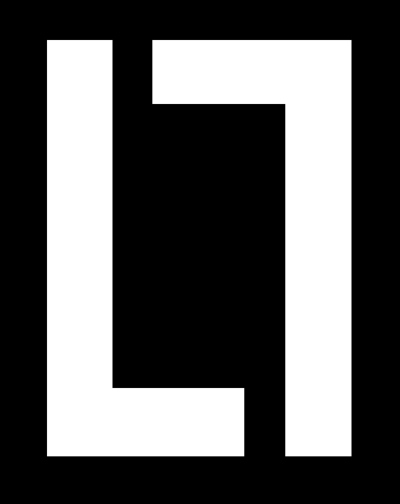La Leggera era il treno che dall'Appennino centrale portava molti lavoratori in Maremma, per la stagione della mietitura. Posso vantare uno zio nato nel 1908 che salpava sulla Leggera.
A chiamare così questo treno furono gli stessi passeggeri, molto probabilmente perché salendo non avevano bagagli per il viaggio ed erano quindi persone “leggere”, senza valige, nessun vestito da portare oltre a quello indossato e pochi oggetti, spesso da condividere: “un soldo di cicca in tasca, un pezzo di pane in tre”.
Il nome del treno divenne presto il titolo di una canzone con cui raccontare la loro condizione lavorativa e le implicazioni socio economiche che ne conseguono.
Il lavoro stagionale che li aspettava al termine della corsa era una forma di precariato, nato dalle crisi di fine ottocento e dallo sviluppo della rete ferroviaria, così la Leggera divenne "style of life" di quella fascia di popolazione privata lentamente, nella seconda metà del XIX secolo, del ruolo professionale che fino ad allora aveva potuto assumere in un determinato territorio.
Indipendentemente dalla propria onestà e buona volontà si viveva in stato di crisi, sapendo che l’anno venturo sarebbe ripassato il treno, diventato metafora del lavoro occasionale, altamente sottopagato, lavoro senza coinvolgimento particolare, fatto per necessità, lavoro cercato perché oberati dai debiti contratti in paese data l’endemica disoccupazione, per cui la paga servirà solo per onorali. Nella realtà dei fatti quel tipo di lavoro comportava presenza di caporalato, controllo, fatica fisica ed un grande disagio tra sporcizia e malattie nei ricoveri, il tutto a monte di paghe molto inferiori in rapporto alle ore lavorate. I braccianti meridionali e centroafricani della nostra penisola possono essere un esempio di come il fenomeno sia tutt’altro che storicizzato.
Fare il bracciante non era quindi il sogno o l’ambizione dei ceti artigiani e nemmeno dei contadini, abituati al coinvolgimento implicito nel loro lavoro attraverso il metodo o “mestiere” ed il conseguente risultato, si trovavano ora svuotati di ogni partecipazione emotiva, in un’occupazione delocalizzata, a tempo determinato e che richiedeva soltanto mero sforzo fisico.
Così essere una Leggera era sinonimo di disperazione per la maggior parte di loro, ma testo e ritmo della canzone nata da quell’esperienza non ci restituiscono questo disagio: ritrovandosi davanti all’incertezza e all’instabilità quelle persone seppero ridefinirsi nelle caratteristiche degli spiriti più irresponsabili e avventurieri, come vagabondi, debitori incalliti ed altre figure, appassionate di tutto fuorché del lavoro e dei cui atteggiamenti scanzonati fecero di necessità virtù.
Difatti, se tutta una massa imponente di lavoratori coagulava la figura della Leggera unicamente nell’individuo che sfugge o cerca di sfuggire in mille modi all’impegno o alle fatiche, in colui che approccia senza nessun trasporto un’esperienza lavorativa, questo è probabilmente perché quel profilo, per quanto non maggioritario, rappresentava tanto un atteggiamento di buona resilienza verso le avvilenti difficoltà, sia un boicottaggio, una singolare rivolta in seno alla costrizione. Cantare coralmente un testo amplifica il messaggio che contiene, cantare tutti La Leggera, unire tutte le voci raccontando quel modo d’essere irresponsabile e sfuggente, manteneva il distacco che le fatiche concrete e l’umiliazione rendevano necessario, oltre ad amplificare a mille voci il danno che avrebbe dovuto subire l’ingiusto sfruttatore per la negligenza contenuta in quei propositi.
E’ stata Caterina Bueno, grazie alla sua ricerca, a trascriverla e registrarla sulla base dalla testimonianza di un vecchio stornellatore del Casentino, solo una strofa è comune a quella (più scarna) che si canta nel mio paese, in Umbria, mentre altre strofe coincidono con racconti attorno ad un tipo chiamato appunto “La Leggera”. Sulla presenza in più regioni di medesime storie attribuite a diverse “Leggere” non credo ci sia da dilungarsi troppo, dato che il fenomeno rientra negli stilemi della tradizione orale.
La prima cosa che si nota in questo testo, tolta la parte centrale dove si racconta la settimana (non)lavorativa della Leggera, è la presenza di frammenti di pensieri, ritagli di altri canti simili, massime e apoftegmi caustici che potrebbero essere posizionati indifferentemente in apertura o in chiusura, proprio come si addice alla struttura del canto popolare: una mancanza di filo narrativo stabile, niente rigidità dello schema “inizio-svolgimento-fine” , oltre ad un’assenza di dramma esplicito.
Si riscontra difatti la non necessità di sviluppare aspetti che erano invece familiari alla produzione artistica di altri ceti sociali contemporanei, come ad esempio il rapporto madre/figlio, casa/ricordo, amore/lontananza, paesaggio/sfondo emotivo, sensazione/sentimento, e via di seguito, e che verranno introdotti nei canti popolari da autori di estrazione borghese, declinando quei temi a loro cari in versione proletaria. In questi casi solitamente abbiamo un oggetto: la proprietà (materiale o affettiva) e a seguire malinconia/umiliazione per la perdita o il difficile raggiungimento di questa.
Proprio nella seconda metà del XIX secolo e a cavallo con il XX è avvenuta una delle tante ibridazioni tra la matrice orale del canto popolare e la struttura del testo scritto.
Il fenomeno era dovuto tanto allo sviluppo della neonata cultura di massa che all’attenzione posta verso il tema bruciante dell’emancipazione sociale. L’autore di estrazione borghese, sviluppando testi per sconvolgere o coinvolgere l’attenzione del suo pubblico, non poteva che utilizzare quella struttura narrativa razionale affine al lettore di romanzi d’appendice, allo spettatore teatrale prima e cinematografico poi, e via fino ai linguaggi di certa arte engagée.
Tutto questo ha portato un approccio ed una lettura spuria se non distorta del Lumpenproletariat di allora, lettura parziale che arriva fino ai nostri giorni. Così come il Neoclassicismo rese bianco latte un Partenone coloratissimo e scintillante, la lettura del basso proletariato è oggi tristemente relegata alla “rabbia ed il dolore” o alla “dignità e sofferenza”, con connotati patetici e nel migliore dei casi sincronici al solo raggiungimento degli obiettivi, ora del modello capitalistico ora del modello socialista. Così si sono sacrificati sull’altare della narrazione sterilizzata i pilastri di quella cultura, ovvero l’ironia e l’intelligenza intuitiva, che ne hanno decretato la sopravvivenza materiale e la potente creatività. “Colore” e “folclore” vengono chiamati spesso, rinunciando a contenuti oltremodo fecondi.
Eppure, nell’industria culturale, le gocce di questa linfa sopravviveranno distillate non poco, nel cinema muto, grazie al profilo del “vagabondo” disegnato da Buster Keaton.
Tornando alla forma del testo de “La Leggera” si nota invece come la sua “instabilità” orale, tra strofe che possono apparire tranci di filastrocche infantili, ai limiti del nonsense, onomatopee e immagini, altro non fanno se non mimetizzare proprio l'ironia feroce dei significati. Cataclismi sociali vengono espressi in segmenti di pensiero: sul treno che porta alla mietitura sono “senza stivali e tutti tacconai”, fine del mestiere inteso come “essere ciò che si fa”, è un passaggio epocale che apre a taylorismi e fordismi che giravoltano fino alla nostra organizzazione sociale, ma La Leggera osserva e irride, pare un attore di quelli che hanno a che fare con un regista isterico, che cambia in corsa il profilo del personaggio. Gli chiede quindi: “chi vuoi che io sia?”, con un’accondiscendenza che altro non è se non togliersi il primo problema, ovvero capire il suo nuovo ruolo , ma nel fondo:
“Alla Leggera poco gliene importa,
manda sull’ostia la fabbrica e il padron”.
Anche se superficialmente adattabile La Leggera non è però una maschera come Arlecchino o Pulcinella, alla fine dell’Ottocento le masse sono ormai entrate nella Storia, è impossibile evocare entità apotropaiche. Non può nemmeno essere un picaro, nel quale può scorgere il suo antenato sulla soglia della modernità, ma il picaro aderisce tutto alla sua epoca, le tante peripezie che compie non fanno che rimbalzarlo come una palla di pezza in un gioco stabilito, tra la forca della Ley e il perdòn de Dios.
La Leggera è un essere in carne ed ossa che possiede la sua identità radicata nei millenni, ma questa non aderisce più a ciò che è utile, così si mimetizza, si metterà una maschera e non quella popolare, tradizionale, ma quella che gli si dice di mettere: operaio, bracciante stagionale, mozzo. La compagnia teatrale è una Società per Azioni.
Soffrirà nella fatica fisica che gli reca quella maschera e cercherà di definire spazi quanto più circoscritti di sofferenza perché la sua essenza non partecipa a quel processo che non gli appartiene, agisce sospendendo l’essere, si reca in luoghi dove altri hanno investito la potenza del nuovo mondo, il denaro, ma che non riconosce come utili al suo esistere. Porta la maschera fino a che:
“(…) mi metto in un cantone
Aspetto il padrone
Che mi venga a pagà”
Da lì saldare i debiti e riprendere in mano la propria vita, respirare, o nel caso avessimo a che fare con vere Leggere, scansare il creditore, affittare un vestito, pagarsi un bagno e correre in questo o quel caffè di una capitale, in questo o quel teatro, bordello o dove volete. Ma che sul trenino del ritorno siano il probo o l’empio, entrambi torneranno a loro stessi.
Questo distacco della Leggera, il suo scivolare dai contesti, si legge nella canzone quando avvertiamo l'assenza di rimandi ad una “morale della storia”, a un Domani o alla Provvidenza. Dalle masse anonime, passive e lunari per il reazionario, motore della storia per il rivoluzionario, emerge una psiche monadica, che vive nel collettivo ma abituata per necessità ad essere presente a se stessa, in grande confidenza con il “qui e ora”, che i ceti “amici” inseguono per lande New-Age e orientalismi speculativi solo adesso che, anche per loro, il ragionare a “lungo termine” è stato precluso.
Questa popolazione ammassata sul trenino che va a lavorare non intende il Sol dell’Avvenire, e non sa che farsene del Paradiso, per il socialista da II Internazionale costoro “non sanno ancora”, per il prete da Rerum Novarum “non sanno più”, accecati dal materialismo. Per entrambi si diventa una Leggera per via del danno che ogni parte individuerà come “il problema”, non considerano che “alla Leggera poco gliene importa”, perché questo annienterebbe le loro “cure” e il loro ruolo. Ma non sarà piuttosto che quelle masse erano “immobili” in una percezione del tempo e dell’esistenza che li preserva comunque dall’invisibile ballo del futuro? Non ci si dice oggi che, per sfuggire agli squilibri che ci arrecano input e sconvolgimenti continui, è utile affrancarsi dal peso dello ieri e del domani attraverso pratiche tra le quali, una, è l’astenersi dal demandare tutto a questi due invisibili? E chi se non un individuo già privato di passato e di futuro è predisposto a questo tipo di considerazione dell’esistenza?
Grande valore ha poi la concentrazione del pensiero, l’esercizio mentale che aiuta a non frantumare l’attenzione oltre la presenza, e su quel treno abbiamo innegabilmente una massa che non trae alcuna utilità dall’inanellare dati che superino gli eventi in corso, laddove il disegno del pensiero è relativo alla concretezza del momento oppure si astiene, a seconda di ciò che si avverte utile o meno. Questo si riflette nel linguaggio: il pensiero scalfisce la frase netta, riassume e brucia il concetto con la bordata detta spesso in rima, per saldare il senso al ritmo, poi il silenzio. Terminata la strofa o la semplice la battuta, chi l’ha pronunciata tace, l’ascoltatore ride: le sentenze degli ultimi non ricadono a pioggia sulla società, non c’è una fascia successiva che le deve cogliere o subire, emergono dopo aver assorbito e poi condensato tutto quello che è avvenuto prima, sigillano il ciclo: sono il definitivo memento mori, quindi portano anche il riso sulla soglia del sepolcro.
“E finché fiocca a ‘sta maniera
la Leggera trionferà!”
Finché nevica così abbondantemente La Leggera trionfa, si sta a casa, non si lavora. Strofa non presente in questa versione ma in quella dell’appennino umbro-marchigiano. L’immobilità permette il trionfo: la Leggera non ha bisogno del Daodejing per restare nella vuota verità del Tao.
Passivi e spietati, ecco come sono i poveri e gli dei secondo una constatazione comune e, se le religioni avvalorano da sempre la metafisica dei pezzenti, garantendone la passiva sopravvivenza, la civiltà laica cerca di togliere quell’assuefazione alla spietatezza ineluttabile, privandoli per certi versi della loro aura metafisica. Ma la Leggera non è il mendicante di Samarcanda o il Paria attorno al tempio Indù, non vive qui come se stesse già nell’inverso corrispondente della rinascita o della resurrezione, e gli dei sono sì immobili come vorrebbe essere la Leggera, eppure il loro atteggiamento ricorda un ceto medio che briga anche nel tempo libero: fanno, disfanno, tradiscono, aprono bottega, litigano, la chiudono, tutto dalla base sicura dei piedistalli di marmo.
La Leggera si muove, non sta ferma come il mendicante o la statua di una divinità, va in Maremma e nell’Agro Pontino, arriva fino in Brasile a raccogliere caffè, va negli Stati Uniti, in Canada, si infila nelle miniere del Belgio. La sua condizione le impone di dover partecipare, ma il proposito è “non voglio lavorà”, così facendo è la goccia di veleno del Mondo Moderno, non l’antidoto ascetico o politico alla frenesia che lo domina. Ecco perché, pur restando alla base infima della piramide sociale minaccia ogni sistema socioeconomico che la coopta, sia esso lecito o illecito, ingiusto o solidale, affermando che se “alla Leggera ije gira la testa oggi lavora domani fa festa”.
E’ ovunque nel mondo ma non per un fine, l’idea di sviluppo gli scivola via, d'altronde “sviluppo” è una questione eminentemente pratica da svolgersi nel tempo e, se La Leggera non vive in un “oltre metafisico”, di sicuro non corre appresso all’orologio dello sviluppo. Sta nel momento, ma quel “momento” non viene riconosciuto, infatti la rimproverano di vivere “alla giornata”, modo di dire che intende la singola giornata lavorativa, senza certezze verso le giornate future. Parola che dice della voglia di non lavorare, ma desunta dal gergo lavorativo, la Leggera scuote la testa per questo blocco invalicabile del nostro linguaggio.
Anni fa mi capitò di stare per un paio di giorni con un anziano muratore, stava facendo un marciapiede intorno a casa e dovevo aiutarlo. Mi raccontava della sua vita, il lavoro all’estero, l’emanciparsi della sua generazione dall’agricoltura stentorea del pedemontano a forza lavoro attiva, la generazione appena precedente a quella di mio padre, con aspetti identici alla sua, differente però dalla mia, che ha visto incrinarsi l’albero maestro. E difatti gli chiedevo di andare indietro rispetto ai suoi anni postbellici, ancora più indietro, cercando la differenza. Finì con il parlare della sua infanzia e mi riferì come i vecchi d’allora, con cui intraprese il mestiere da ragazzino, usavano esprimersi a filastrocche durante il loro lavoro. Quegli uomini nati tra il XIX e il XX secolo cantilenando scandivano i passaggi delle varie azioni, o lo scambio dei secchi di cemento su per le scale. Si esprimevano per tutto il tempo così, o tacevano. Mi venne in mente subito “il mì nonno fava i matòni” di Amarcord. Doveva essere davvero una caratteristica forte se Fellini rappresentò, in un film sulla sua infanzia, un vecchio manovale decrepito che poetava.
Il signore ricordava un paio di strofe e me le disse, erano davvero insensate, c’erano dentro mucche, nuvole, vino, pifferi, l’azione del volo era giustamente ovunque, “ma vedi” aggiunse subito, “i vecchi nostri erano sempliciotti, voglio dire, non ci stavano tanto con la testa, erano così.”
Può sembrare una conclusione cruda, ma c’è molta innocenza in quel giudizio che corrisponde a come la nostra psiche legge le differenti percezioni della realtà.