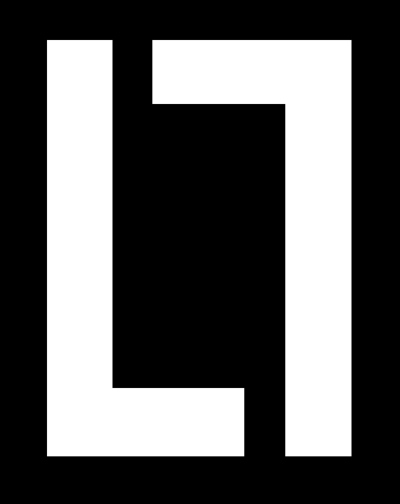Strauss
Inaugura
Presso
Partecipa
Fino a
Strauss
Comunicato
Stanotte, verso le quattro, ho pensato a Strauss. Senza alcunché di preparazione, di punto in bianco; né la minima avvisaglia schizzata dall’andatura china con volatili passi “nell’inscurità” di labili viottoli o dietro solidi e stabili tragitti di mnemotecnica; silenzio – c’era già – e, appunto, ad un tratto Strauss, che col silenzio ha assai poco a che vedere. C’è però quella esse che avanza punto, punto, punto Cu silenziu ra notti avi picca a chi viriri, dittu ’nsicilianu. Naturalmente mittennuci a notti.
A meno di una o e di una u, come anagramma di Sostra. Anagramma imperfetto – solo per questo? Sì, mi ritengo appagato; soddisfatto sono –: Anagrammavo, disteso e sveglio, coperto ma come sempre nudo, come un animale, d’estate e d’inverno, stamattina (mi trovo più a mio agio a chiamarla così, a darle questo improprio nome), tra l’ultimo sogno della notte e il sogno in attesa (quale genealogia avrà?) “del mattino che verrà”, in forma e costruzione; morale della notte: dopo di me il mattino, e dopo il giorno il buio – lungo l’impronta iniziale di Sicula; la linea serpentina nella tavolozza di Hogarth col carlino, da H ad H; Tavolozza, tavolozza! Ovali annunciati, allora dissi y scrissi, abbattendo scenografie, meglio immateriali quinte di vacante, poco pesante, tutta velata tremante materia e piramidali prospettive di facciate intavolate, appartate tra prosaici stucchi cascanti, terremotate tinozze d’acqua piovana e lavandaie matrone trasteverine –. Il miracolo, che alcuni risparmia e altri fa morire sepolti da macerie! C’è ancora molto da costruire nella testa di tanta gentesca che casca e ricasca nell’assurdo, come conigli presi al laccio sì di rame cotto mentri vannu ’nto trippiaturi; o tornano cuntenti. Non c’è spazio per il piacere, solo l’acuto grido di dolore, l’ottava nota, il do con la i posticcia ha campo libero, sulla sofferenza si ricostruisce il crollato culto: le case possono aspettare. C’è tanto ancora da edificare nella testa della gente, la gente che… Ma poi, a che pro? Per averne di ritorno che? Eh?
Gatti, pipistrelli, rane, cavalletto contro leggio, tela su tela, margherite, gatti; cravatte. Tavolozze di lillà; gatti, di vuoti e di pieni: Il nero che non dipinsi, quella prospettiva di mano, che da giovane usai; così, spesso, con essa, competenza e abilità pensavo di misurare. Pieghe e nocche, curve e luci, scorci e proporzioni, trasparenze e contrasti, incavi e rilievi, chiari e verdi di corpi esangui in un da poco patentato artista nel suo casciabbanco faggio che diverrà ispido e salino castagno di danzanti bolle. In un luogo polifilo il cui vero nome era Modulo4.
La testa che cammina.
Era necessario dare riconoscibilità allo strumento, quand’anche nella mancata interezza: connotati in realtà – fino a che punto? – mancanti – in altezza? a caso una nota e mirata (che ossimoro!), oppure qualsiasi fossero esse, dicasi le altezze, le stravaganti e abbondanti altezze, istoriate in tempi andati? comandate? feste andate a male? carne scatolata e purulenta? – ma identità salva e buona condotta condannata.
Nella rimozione di una parte. Quale legno o metallo? Non è detto che in cima ci sia la testa e in fondo i piedi. Passabile, questo, per quanto riguarda gli umani. Bosco ne ha costruiti di corpi mancanti di proprie parti: ognuno di essi potrebbe diventare un mito, una credenza, una divinità figlia di divinità, che nasce, muore e risorge, nasce senza nascere e muore senza morire. E risorge, ovviamente senza risorgere, che credenza preistorica, senza punto e punto e virgola, è insopportabilmente enorme il baratro di questa persistenza, e porterà alla rovina di un concludente in-conclusivo crollo, della dormizia eterna, la “in” – tre apostrofi erano troppi – della scurità perenne, senza giocattoli paradisiaci e stupiderie simboliche. L’en plein air ha spazzato via tutta la pittura di questo genere di consolazioni mortifere e tristi. La testa degli umani ha fabbricato la plastica; sì, sorridendo alla conquista, coi suoi equipaggi segnati e armati l’ha messa in circolo guardandosi bene dal piegarla a sé e strappare da sé dopo l’uso quest’idea bianca e soffocante. In uno strozzamento da grovigli mentali, la fine di tutto, e spazio, quando sarà, a esseri che godranno la vita anziché odiarla, vivranno in realtà senza garbugli e non in macabri oltremondi di loro truce invenzione. Spazio alla vita senza uno scopo, senza un fine, senza un perché. Lo scopo è la vita stessa, il fine è la vita stessa, il perché è la vita stessa. Provate a contare quanti morti ha generato, millennio dopo millennio, tra gli umani l’idea dell’oltremondo. Provate adesso a pensare a che tipo di utilità abbia potuto avere questa idea deformante: nessuna. Solo una ristrettissima cerchia ne ha beneficiato, quella che su tali invenzioni da sempre lautamente ci campa e sguazza, tra spudorati lussi e compiacenti artisti.
Tolta la pancia, tolti i polmoni, le interiora, vagina e fallo, ma la riconoscibilità è salva da cima a fondo. La cassa armonica non serve in un suono immaginato, che è vivo nella testa, tra varie corde interrotte da due file di onde. Nel corridoio tra due ondulate pareti di legno, la continuità che manca, la non necessaria descrizione, il non necessario suono: è nel sorriso del mare che a sorpresa si ritrova la musica. Noi, acqua nell’acqua; lì ritorneremo. Noi, non polvere alla polvere – il gallo ha alzato la cresta in queste parole tristi tristi –, ma acqua pulita in quantità in acqua pulita in quantità. Noi, non acqua lorda di peccato da lavare, ma acqua dolce e acqua salata con le salubri squame, di rettili e pesci.
Il mare, il Cavaliere “senza” rosa di Strauss. Gli fa eco il nome di quel fiore assente. Ei fu: musica a programma; dopo di me il di… case su case e acqua sporca.
Le nozze di Figaro. Il teatro, l’opera.
Le Alpi sonore di Strauss. L’aria di montagna di Nietzsche.
Dal davanti in riflessione al suono secato. Non si trattava di particolare riflesso, bensì di interezza doppiata da duplice luce.
Nella Torre di Babele di allora, una breve porzione di mare; oggi l’orizzonte e il suo doppio virtuale capovolto si tingono di nulla. Tra l’uno e l’altro, tempo e spazio di ciò che fu, e lasciano emergere, ognuno per proprio conto, ciò che ora rimane; tengono, uno emerso, l’altro sommerso – prendendo, di quando in quando, uno il posto dell’altro, il primo il posto del secondo che diverrà primo e viceversa –, quanto ancora da rosicare miagolando per affilare i denti. Quanto ancora da abbattere con l’acqua salata del mare – Salt-Theatre –. Il suono da far tacere. E da cancellare. Così sarà silenziato. Così sarà cancellato. Così saranno cancellati colori e suoni che rifiutando l’unico mondo vero fatto di materia, di terra reale, vitale, mondo di carne e ossa, gioioso se lo si vuole, inducono, con le loro inique armate di subdoli forme, colori, suoni, parole, agli oltremondi di lugubre invenzione, millenaria monotonia, mortifera fantasia, immateriali e fasulli sotto le insegne di sofferenza, dolore, rinuncia, perdizione, peccato, spedizioni punitive, cappesante d’oro. Via, buie volte che tanta sofferenza si sono compiaciute di guardare – è quella, insieme all’ignoranza, la patina del trapassato che copre vetri, tavole, tele, marmi, intonaci, ori, ricami, argenti, bronzi e legni –, che tante speranze malriposte tra freddi puntali di archi hanno accolto! Di nuovo o e u. Welcome aria aperta! Welcome! Welcome to my house Mr Harker! Bienvenu, vent’anni prima.
Welcome primi anni Settanta! Tra La nascita della tragedia ed En plein air! Quali errori hanno fatto sì che tutto questo venisse dimenticato? Come è stato possibile che gli umani abbiano messo da parte il patrimonio che allora fu loro dato? non rinunciando a credere, almeno una parte di essi – e, cosa ancor più grave, alcuni tra coloro i quali hanno in mano le redini delle direzioni da prendere e delle scelte che tanti poi vengono costretti a fare –, alle assurdità paradossali e frenanti che anche una dose minima di cervello dovrebbe riuscire a riconoscere come tali? Come possono gli umani da un canto andare da un pianeta all’altro, dall’altro rimanere ancora abbarbicati a tali stupidaggini? Quale salto permette tasimi incongruenza? l’è? È, minuscolo e maiuscolo sono invenzioni delle paure comuni agli umani. Le paure di morire e sparire. Su queste, menti fameliche campano; sulla paura del buio e della dimenticanza gli imbroglioni hanno costruito la loro miserabile (pure la questua!) e smisurata ricchezza materiale, non di favola come le loro stramberie propinate agli ingenui che ancora credono alle nuvole parlanti e ai pomi indigesti.
Di ogni strumento ho dovuto scegliere quale parte mantenere visibile e quale, tra le due file di onde – una fila reale e una virtuale, cioè l’immagine riflessa –, far sparire, cancellare, diluire nel passato, diluire no, far assorbire dal nulla che è il passato. Strumento per strumento ho attraversato, sorvolato, saltato, superato i problemi formali che man mano venivano a porsi. Fino a quello, al quale pensavo fin dall’inizio, e che fin dall’inizio vedevo non come problema da risolvere; era, invece, una forma felice da disegnare, che, a sua volta, forme in movimento disegnava, non linee ma suoni: la bacchetta del direttore d’orchestra.
La parte superiore con riccio, cavigliere, capotasto e una parte della tastiera; quella inferiore con bottone, cordiera e tavola armonica fino al tendicantino. Questo per quanto riguarda il violino, la viola, il violoncello, il contrabbasso.
Il clavicembalo e il liuto hanno corpo di gatto oppure di ratto per cassa di risonanza. Mi è stato suggerito da un pianto, un lamento, un canto d’amore, un dialogo serrato tra due gatti, e da uno scricchiolio proveniente da dietro una tenda, un rosicchiar di topo. Il primo rumore, anzi il secondo, anzi il terzo, del primo giorno; della prima mattina del primo giorno, del primo anno: un quadrato di carta che cadde, do e via. Re. Un segnalibro stampato e scritto, per segnare non una pagina ma l’apertura tra due pagine, due qualunque tra più di duecento, h.i.m., in queste “ri” – H, ospedale, silenzio, parole di testa di un vecchio opuscolo di poesia che ogni tanto mi tornano in mente – “la storia, ah, la storia!” ci sono alcune punte, ma molte pianure tra loro simili nella lettura e nel ricordo uguali. Punte stuzzicanti e non dolenti di un passato perduto, di occasioni mancate, di proficua, solitaria indipendenza, di romantica attesa: ottant’anni giusti, dal ’16 al ’96, da rivivere, decennio dopo decennio, togliendo le amputazioni e aggiungendo l’anestesia. Ottanta che con l’uno seguente iniziano a tornare o col precedente sono già tornati. È già sabato! è già venerdì, è già giovedì, è già mercoledì, è già martedì, è già lunedì. Già. Molta strada non si fa col mal di schiena. Sì verso il sol tramontante. L’astro di Zarathustra.
L’impero delle luci è un dipinto da tutti – o quasi – conosciuto del Signor Magritte, che in riproduzione, ovviamente su carta, ebbimo in dimensioni rispettabili 70x100, come capoletto nella camera, grande camera da letto con due cerule finestre, della prima casa di via Cuniolo. Dove c’è la luna c’è anche il sole, disse una volta chi non si chiamava ancora Sostra e non si chiamava Feliscatus; con arance di ftalocianina dipinse una notturna tela, di otto decimetri in altezza e sei in larghezza, tutt’e due misure occupate, in gran parte della loro estensione, dal vuoto. È il sonno anche di giorno, gli premette “chiarire” usando tale geometria siderea incontro alle tinte, su spazi aperti ed elementi pochi.
Se è sorprendente e straniante il cielo, del proprio diurno colore, che sopra sta alla sottostante campagna buia e notturna – per molto sopra, con le sue belle nuvole significanti, ossia le forme che prende l’aria brumosa, indefinita, dai contorni confusi, l’aria lontana dell’orizzonte, le forme rigonfie e lievitanti, tra il grigio bombato e il bianco a smerlo tondo in cui il vapore s’addensa approssimandosi, con uno sguardo arcuato e un’alzata di mento, verso la perpendicolare –, allo stesso carattere di appetitosa surrealtà potrebbe far salire l’occhio devoto dal mare in su. In realtà, vicino alla superficie dell’acqua così non è, non c’è fantasticheria magrittiana che tenga né palpabile o impalpabile visione freudiana, né curvi sogni a occhi chiusi e ciglia bovine aperte o rasoi e pugnali di Carmen andaluse: Breton resta fermo sulle sue posizioni, e quelle dei cadaveri squisiti. E perciò non torna sui suoi passi. Catene e catenelle, ganci da macellai per appendere cadaveri e sai. Due macabri millenni di gusto per la morte. Cancelliamo, mille ed ennio; gomma sulla carta, cancellino su lavagna, sbiancante se stampato, ramazza allorché scritti tra scalini di radici brevi infisse a terra e friabile armatura di pale secche (rami e puncigghiuna cull’occhi a mandorla): i ’mpirugghiaperi; il martello è ciò che occorre, trovandosi, trovandoli in litici rilievi; mille ed ennio, per farne sparire ogni ancorché debole traccia. Si riparte da capo, si ricomincia dall’anno zero. Anno di Zara-Sostra. Da ritenersi normale in una sezione verticale – l’aria e l’acqua tranciate di netto – che dal cielo passi al mare, dalla bruma all’acqua, dall’acqua all’aria. Alcioni isolotti di sentimenti, punto d’incontro delle onde, gelide acque e schiuma bianca, pelle d’alabastro – Il regno della luce. L’impero delle luci. L’intero della luce, così ho pensato di chiamare le onde stese ad asciugare dopo la vendita all’occhiello a vite, all’asta di note, le note all’incanto nell’aria fine dell’alta montagna di Strauss. Uno e ancora uno fanno tre; legna, carbone e calce, l’insieme dei bruni, l’insieme dei bianchi: bruni crudi e calcinati; nero d’ossa, nero di vite; bianco d’argento, bianco di zinco, titanium white. Arriva il vecchio Atlante. All’ocra della terra, al buio di legna e carbone, al bagno di luce di fumetti adolescenziali, quegl’impeccabili tagli d’ombre che Magnus non seppe poi stendere disegnando Tex – l’urgenza di neri fu da me recuperata e messa in Felix Willer –, perdendosi, per inopportuna riverenza, nel debole profilo di migliaia di foglie, a questo prolisso delirio di colori, luci, e suoni, di chiaroscuri veri e mancati – con annesso Frère Jacques –, si somma il blu oltremare del mare. Di manti e lapislazuli non sappiamo che farcene, gli azzurri preziosi lassamuli ’ntinagghiati. Uno strato appresso all’altro dà la percezione dell’azzurro, è l’oltretono di Giorgione, musico e pittore. Se è un fenicottero l’airone sul tetto, è della luce che annuncia la nascita.
Il crogiuolo della linotype filosofale.
Un dipinto a due dimensioni, per meglio dire piani, a due piani, Il regno delle luci, anche nel titolo, regno e luci, impero e luce, assente, presente, quella artificiale serve a confermare, dell’altra, l’assenza. Piano del paesaggio, sfondo su un piano verticale; anche il paesaggio, casa compresa, ha una sistemazione verticale a due dimensioni. Due stadi di colore e tono, notturno/diurno, chiaro/scuro. La profondità verso l’orizzonte lattoide cagliato qui manca. Si intuisce che dovrebbe stare dietro gli alberi, ma di fatto non si vede, quindi non c’è; ritorniamo al piombo appena sciolto di prima: due sono le dimensioni, la pittura queste ci fa vedere, di conseguenza – sempre odore di origano secco nei gomiti metallici – è così. Così si espresse l’Impero delle luci, e noi lo comprendemmo, diventammo noi, io, il pittore, e mia moglie che allora dipinsi in tanti quadri, la terza dimensione.
Quei graffi, quelle incisioni, non si vestirono “di” ma si denudarono “in” significati che andarono al di là dello scopo per il quale erano stati operati, l’artigliamento settembrino schermava il calore scovando l’umore di radici di terra; sconfinando dallo stretto appiglio estetico, superava i limiti dell’estetica quale cagione e fine, ponendosi al di là dell’apparenza come fondo, superficie e proiezione, scavalcando e galoppando sopra il mondo piccolo e ancora piccolo che unito ad altri, e poi seimilasettanta volte tolto, strappato appare, il biforcuto luogo dell’al di là del bene e del male.
I motivi dei graffi si sono chiusi, la realtà d’origine è stata coperta. Ne rimane l’immagine che ha rilievo e spessore d’inchiostro, in parte assorbito dalla carta; scultura d’intaglio minima minima; in su, in giù. Incavi e veri rilievi – veri altresì gl’incavi – fanno parte di un mondo a sé, di uno stato a sé stante e schermitore astrale – ivi ci si posiziona fermi e bene, alfabeto e note di mezzo da un traliccio all’altro – tra legno e legno attaccati da vinilcolla. Se ambedue contendenti, armati di bastoni e con le gambe fino alle ginocchia interrate, si volessero staccare – ah, quel nero che lì non si vede ma è nero quanto lo è altrove di scopo; ah, da muro a tela, dal fiato ad una teca, dall’odore di cucina all’odore di silenzio, non più odore doloroso di silenzio –, se si dovessero, se si volessero a forza render disgiunti, si troverebbero, sui lati già di contatto, da una parte e dall’altra, nuovi incavi e nuovi rilievi, alcuni taglienti di legante rappreso, lucido e trasparente il migliore, opaca e mediocremente bianchevole la riserva. Ma a che pro farlo? La realtà è mutevole, muore, si trasforma, l’immagine resta… finché resta, ed essa basta, finché basta. Resta (di nuovo) il suono, il fruscio, ’na sciusciatina di svista, un fugace ronzio, appena il fruscio della parola fu la f di fine, la u dell’articolo una, una fine, la fine, The end, poi la materia dice: “Questa è un’altra storia”, non la prima, non la seconda, non l’ennesima prima, né l’ennesima dopo, né prima né dopo né là, nella sana follia circolare di parola e materia.
Federico secondo e primo, e l’eterno, l’esterno, l’interno ritorno. La sensazione della realtà e la sua immagine tra due lembi scostati di tessuto lavorato, perlaceo a jaquard (cinquant’anni dopo, tale condotta porterà la parola ordita), con un filo arcuato, incrociato verso il basso, cuce un bottone mancante di un’asola perduta, il Prado chiude la colonna di libri, lì dentro c’è dell’ombra scura – In Spagna, a quel tempo c’è buttavia del marcio – tuniche criminali – rendere piatti gli – punto – assi, azzerarli, piallarli, piantarli con la z ad altezza d’ombelico. Circonvoluzioni ed elettricità nel poco al di sopra – due, tre etti non sono pochi, l’unico vero esorbitante al di là, magari è lì che per la vergogna si nasconde, movendo gl’impulsi accelerati di soppiatto, il bisogno di credenza e d’ignoranza – di un chilo di materia molle destinata a sciogliersi come meduse spiaggiate al sole di luglio, con i serpenti che da tutte le parti scappano, con l’acqua dei serpenti che corre verso il mare, capelli e ossa secche, detto a denti stretti, è ciò che rimane appeso all’albero insaponato della cuccagna, sai che avanzando salgono e salendo scivolano sulle impalate loro convinzioni.
Tengo la riproduzione ancora stretta tra le mani, nella poc’anzi detta forma del remoto tempo; con avemmo vuoti palmi avrei da tanto. Lo scolapasta di Don Chisciotte a coprire una tajine; plastica, non metallo, su terracotta smaltata. Rossa, la plastica, grande più di quanto serve. La nobiltà sulla quale fare affidamento consta di accenti e consonanti. Spaziosi il necessario per contenere, stretti abbastanza per evitare consumo in sovrappiù di spazio esterno. Così resta la forma, stabile il modo, stabile la b, il nome giusto per la settima nota in origine disformante.
L’impero è delle vertiginose luci: come bolle; fili di alghe trasparenti e fluttuanti, sostituti del buio ammasso frondoso traforato di meridiane stelle. Per meno di metà, in velatura sincera e sovversiva oscurità sull’anziano accolito ceruleo posto in piedi (l’acqua dell’onda appesa a un filo colorata d’azzurro). E poi l’oggetto musicale, lo strumento origine del suono, il nero di vuoto e pieno, noi, contorni ricettori del suono in ogni squama della pelle, nei movimenti di sintonia dei peli-antenne, con esteriori ed interiora cassa armonica di musica e manuali suoni, vomitati urli e raggelati comandi, rimesse servitù e sbriciolate autorità. All’erta! Nessuna distrazione, mai abbassare la guardia: sì al salto dal balcone, giù il sarto nei crepacci, qui delle Alpi, sì al poema, il sì alla Sinfonia. Helvetius.
Quintavalle riteneva i quadri di un certo pittore, che evidentemente la sua sfilacciata vista di parlatore d’arte non era in grado di capire, da copertine di Urania.
Di Bruno Caruso – non è l’artista sopra menzionato – ricordo le “sue” cassette di ricci e la moglie che se non sbaglio guidava la galleria Tavolozza, dove vidi una mostra di Clerici che ben si adattava a quelle due stanze col parquet d’un continuo scrìcchio come le scarpe del tipografo Peppino nella rinomata banda. Futurono di sepiolite, le curve copertine di paralleli e meridiani di là di Nettuno, Plutone, e ancora di là, da una tomba egizia ad una laguna asciutta. Fuori da quelle tavole dipinte, in via Libertà, non lontano dal tondo secondo piano di quel poco miserrimo di Arte moderna – ma c’era Von Stuck! Anche Casorati tarlato, ovviamente padre, non il figlio scarso –, La tavolozza (si accontentino di una maiuscula, oppure una alla volta; Picasso utilizzava i giornali, i quotidiani, yo li tagliai a metà, non i fogli, allora le tagliai, le divisi a metà, prima dondoli, poi immanenti, mezzodì e mezzanotte, tutt’e due per il secondo nome), luogo “Schic” di pellicole a terrazze – la chiamai Eva ma avevo gli stivali stretti e male al piede – o di barlumi da orticaria, orticoltura cilicia. Anni settanta: andati; anni novanta, presenti. Tavolozza, tavolozza! Ippocampi, cavalletti, il Signore delle mosche in erba.
Ieri mattina, al mercato, libri; due tra essi, Caruso e Cremonini a cinque euro cadauno; copertina cartonata grigia, telata, qualche punto di ruggine, pagine e pagine, molte in tre centimetri di spessore, custodia anch’essa telata, con nome e cagnomu, stretta, si fatica ad estrarre il libro, tutto questo avanzo di bottello per il primo dei due pittori; la qualifica di disegnatore, per costui siciliano, anche l’appellativo illustratore, a proposito di copertine, di una certa rivista assorbiumore di ascelle come la baguette francese – non gli ufo magrittiani –, sono maggiormente indicati. Formato pressappoco quadrato per il secondo libro, copertina rigida bianca e riproduzione di un dipinto in posizione centrale, solo il cognome appena sotto l’immagine; spessore, metà circa dell’altro. Della scelta sull’inferiore volume, inteso come impasto di superficie e altezza, anche medium, nel bolognese è essenziale, e non si tratta di qualità tra amaro e dolce, piuttosto di sabbiato, assolato oppure salino, sulla scelta, giustappunto (intercalare di una docente di liceo, matematica e geometria), non v’era dubbio alcuno. In galleria l’ho sfogliato bene; periodo ’60-84, edito, in occasione di una mostra di Liotard da Cremona per Gasparo da Salò che dopo secoli sarebbe tornato, appunto nel 1984; le corde non mancano, come pure la bella cioccolataia. Qui si tratta di dolciumi; le brunnie, ci sono le bocce di vetro cu i pirtusa pi’ caramelle – rapi lu pugnu e nesci la manu, proventi figurativi-teologico-letterari di una dottrina fondata sull’espresso maiuscolo e striptease – accoccolate sui banchi di negozi. Spoleto il luogo dell’esposizione, alcune immagini in bianco e nero, tante a colori, qualcuna, per i quadri lunghi in orizzontale, anche a doppia pagina. Una presentazione di Eco, che conoscevo, inchiodata alla parola epifania. La precedeva, nell’ordine dei fogli, il parere di Calvino; le prime gettate mi hanno rifatto desistere dal supposto avviluppato seguito. C’è modo e modo di presentarsi; e il pensiero errato diventa pietra di volta, sotto cui passare piegandosi con palmi giuntati da mischine idee e dita incatenate da cilìci di Tarso; di generazione in generazione si radica il divieto di pensare, il pensiero errato angustia; resi fragili, ci vuole tempo per disincagliarsi da tale sofferenza, insopportabilmente lunga. Pure l’estate vogliono che agli altri si mostri da inverno, si ghiacci, si iberni nella storia, si vesta di freddo e si copra di vergogna – negli altri – quegli altri, non degni del Foro Corso. Il 5 maggio aprirò la mostra, duecento meno due anni dopo; trentacinque giorni prima, il quindicesimo disegno.
Migliori non sono un paio di pagine di un nome che non ricordo – simile a quello di un rinomato cuoco – su quattro appaiate colonne con ampio spazio utile da sfondo. Esplicito. Impiattato sul galateo lessicale di scorticati divani in genuina pelle vegana.
N ed M non sono pari, uno i patti da recidere li ha rotti, l’altro li ha fatti, ineguagliata trappola, botola tra i piedi della storia, terremoto e crollo del Fosso di Roma, dodici lustri in sbrecciate macerie. Cosa rimane? Alta temperatura, tossica febbre, acqua che scorre dalle invadenti fontane lasciate aperte, sale e fuori controllo copre urbe e gente che non vuol capire, non vuol vedere. Quando gli orbi gli occhi li apriranno sarà troppo tardi per correre ai ripari dal diluvio che s’innalza, pediluvio d’acqua lordata, l’altra, la “fantasiosa in discesa” dolce, velenosa e come il fiele amara, ha sortito il suo nefando effetto. Chi sa nuotare soffocherà, chi non sa nuotare pure.
Sì e no, con l’ago verso il no più che incontro al sì, il mare-quarantennale del pittore bolognese-parigino; alla fin fine di maniera, le sbavature, le oberate colature in predestinate vie di debiti d’essenza – fosse acrilico sarebbe stato tutto più contratto –, e tanto scotch, quello che avanza lo sento – il fragore del mare tiepido, serale e a riposo –, lo trovo istoriato e storicizzato, barocco e tortile. Tutte le riproduzioni mi sono sembrate slavate, poco sature di colore; annacquate; ma non è solamente questo: c’è qualcosa di stancante, di ripetitivo; di datato che adesso rifiuto. Dunque, chiudendo con la mano destra il libro bianco, poco è rimasto; bianco in tutti i sensi, come se niente ci fosse dentro riprodotto, in qualche modo evaporato, nel fruscio della carta, negli effetti sonori delle pagine sfogliate; arido, in quanto asciutto, sarebbe un pregio, ma ora manca la secchezza e la calura di ventose, produttive attese di nulla. Così mi sono detto: Tutto qui? Tutta qui la vita di un artista da trentacinque a sessant’anni? Quel che è certo è che l’aggiunta di dipinti, probabilmente eseguiti in quel lungo periodo e qui omessi, non inseriti perché mancanti nell’esposizione antologica temporale che decenni fa poteva suscitare frangenti apostrofe di rimando, oggi non mi avrebbe condotto a cambiare idea.
Poi, a un euro, un libro su 180 e 250 musei, niente che andasse al di là del privo d’interesse conosciuto; qualcosa, forse, ma proprio poco.
Che uomo pio il quinto Pio! Quanta gente ha fatto ammazzare? Quanta torturare? Canonizzato, ovviamente.
Stage degli Innocenti: apprendisti inquisitori.
Io nascevo e decimo Pio prendeva le nuvole a cannonate.
Carafe di stiramenti, schiacciamenti, tagliuzzamenti, affogamenti. Carafe di titoli, indice paolino, Index librorum prohibitorum.
De Borja, tra linea alessandrina e simonia. Borgia: un nome, una garanzia.
Terzo Paolo, Tiziano, giudizio e Sant’Uffizio.
Umanae Vitae di un altro Paolo, crimine contro l’umanità.
Nono Gregorio, quante vite spezzate, quanti delitti combinati, quanta infamia messa in opera. Non esiste un segno grafico che possa esclamare le innumerevoli atrocità di poche parole chiuse da tre virgole, ci limitiamo – plurale di lese vite, di dolore, non d’indorata, ammuttunata e vescicosa maestà – a un semplice punto per i milioni di morti, di corpi macellati, di cadaveri martoriati, di tombe senza nome.
Eccetera eccetera, come dicono i filosofi; non tutti, certuni, che delle spiegazioni sono specialisti, sull’essere che è, sul non essere che non è, sull’essere che è ma sta da un’altra parte, ma se si prova a chiamarlo non risponde, opina e non opina, tentenna, riflette, tentenna ancora un po’. Musica magister! Hangar, paradiso per aerei e arrugginiti container di copertine e vucciria. Artista famulo. Letterale e senza polso. Vai gigantismo, vai tra le fresche frasche, vai, vai con il tuo… Via, via tutti, si comincia dai piedi, per terra, non su insonorizzate ovatte celesti. Musica maestro, musica d’alta montagna.
Senza data. Dismessa. Sedicesimo: nero opaco e nero lucido su nero semilucido. Alle quattro di una notte di dicembre l’inizio; buio, silenzio, solstizio.
Li ho visti gli strumenti con alcune loro parti mancanti, e non mi hanno convinto. Sebbene compresa, la porzione assente della figura iniziale, nel rassicurante sorriso del mare di carta velina, risultava, richiamava, conduceva, spingeva in una via di trappole magiche con pareti d’acqua, corridoi marini e uccisioni in massa ad opera di un’atroce e cruenta, “divina”, paterna fantasia. Testuale, macabra, campanaria, deturpante, spinosa idrofilia.
Sicché ho usato i remi per dirigermi soltanto verso due luoghi e non tre come prima avevo deciso di fare: luogo emerso, luogo sommerso. Fuori dall’acqua, sotto la linea dell’acqua; con la matita sopra il vecchio e liscio smalto azzurro di antica data, coprendo il disegno a matita, nella sua parte immersa, con un fresco e granuloso pastello blu. Due pastelli, per l’esattezza, di due differenti tonalità di blu, prima uno, poi il secondo, meno morbido, che ha ridotto i vuoti, e custodito i suoni dall’orizzonte in giù, verso il basso e le profondità dalle gravi cromie. Il mare: li serberò con cognizione, saprò ben custodirli, i suoni – tolta l’aureolata schiatta, quasi tutti –, e gli strumenti che li hanno generati. Viaggeranno con le correnti, i suoni immanenti. L’aldilà non ha suoni, il “nessun luogo” non può avere strumenti che li producano e spazi che li accolgano.
Sopra una laguna impalata poggia una vecchia città; domani (chiamala ca veni), per grandi navi, non percorsi insinuati nel Grand Canal, ma panoramica vista dei Piombi su sospiri, affanni, silenzio e morte in trasferta d’incunaboli granduchi cosimi, boboli e in una certa misura ancora ribelli fogne. Soddisfazione di amministratori di varia genìa, in fisionomica bautta. Dirigente usuale e tipo: che tipo! Ma questo, credetemi, sarebbe il mare (male) minore, un più serio disastro, serio assai, d’ineffabile rumore (e non suono, niuna orchestrina ad immolarsi) ed entità, si avrebbe con il blocco anfibio dei centri direzionali di città produttive molto maggiori in estensione e densità di umani scellerati e distruttivi. E ancora, dove andare a infilare la transumanza che anche in questa irreparabile disperazione a mani giunte invocherà aiuto dal cielo, la fuga di miliardi di tuniche di cartavetro (vedete voi se internamente blandite o all’attacco per un esterno abraso) dai luoghi di mare?
Il martellamento su Tiresia per servire in un piatto d’inganno l’elezione di Montalbano. Persona e personaggio, finalmente e finalmente, ma va’!
Patetici quelli chi s’apprecanu a una dissueta mano alzata in un nostalgico saluto d’altri tempi che gli eventi, cui quel gesto fa riferimento, hanno già condannato; non da ultimo, e vento d’annunciata catastrofe, il connubio, il disastro dei disastri, il novantenne patto che nacque di ripristino, ratificato anziché cancellato, diciott’anni dopo lo sposalizio di due firme, una delle quali di soppiatto – pompe rosse per chi la rinascita mosse, da parte di un artista convertito a una pittura di salotti buoni e noblesse –; una limatura l’ebbe il tristo accordo, privandolo di qualche vincolo-scoria di troppo davvero, trentasette anni fa, nuovamente i due numeri (e due punti): l’otto – la mia borsa nera da viaggio! – e la sua metà. L’autoritarismo, oggi, viene reso subdolo ed efficace da ben altri mezzi, e colpisce quando la gente è stanca e con le difese appiattite su poltrone, sedie e sofà; è presente nell’etere, in misura maggiore allorché è impastato con sonno e silenzio notturni; per cui non uno ma tanti vengono guidati ad agire in una certa maniera e a fare scelte che loro non hanno scelto di fare ma altri.
Coloro i quali fanno le presentazioni sanno di essere loro i primi a presentarsi; autorappresentazione attraverso, referenze di sé per mezzo di, autodafé sperimentato e condotto; Vasari copostipite e seguenti, Pio, di nuovo il quinto Pio; atto di fede, in un senso e nell’altro. Il volto di Don Chisciotte, il volto di Frankenstein, di Colombo in Ovumunnu, quel profilo fu causa, esplorazione, conquista: ruina-ritratto-autoritratto; sarà lo stesso volto a riparare dando le sembianze a Federico-Zarathustra e Nietzsche-Sostra. Atto di fede, cerimonie e rogo – è singolare, la fiamma è una, la mentalità una e trina –, artisti e non artisti, e potenti comunque, per cultura criminali.
Obiettivo: ridurre a due, tre grammi di digeribile tossicità tollerabile il bisogno di credenza, dovreste farcela senza tanti sforzi. È sufficiente a coprirli a manta di un passaggiu svulazzanti, pi tantu poi veni u suli – cu so’ tempu – e asciuga rogghi e stinnicchi. 400 anni di paure e angustia, occorrono altri anni, molti, per liberarsi da tale sofferenza – l’ho detto, da qualche parte, giorni fa – distruttiva, devastante, insopportabilmente lunga, arcuata e di appuntiti pinnacoli munita, guarnita, firmata.
Non devono essere ribaltate la L di luce e la L di luna, neppure la sola L di luna. È la L di luce ad esser riflessa, equidistante dall’invero trasparente vetro sullo strato argenteo di gelosa proprietà. Ma dietro non c’è nulla. Specchio: l’immagine sminuzzata di scoppuli in pinzimonio e denti feriti. È così? No. Se ci sei batti un colpo. Erano i furbi truffatori di certe sedute. Specchio: segatura di onde virtuali. Stracci d’immagini/immagini di stracci e segni di vecchiaia, macchie epidermiche e ossidi d’argento. Clorofilla metallica, umide colature e bolle di distacco, linee e cappelli appesi, tolti come accenti di vocali smarrite, Dracula non si riflette.
Ora ricordo: 25.2.19, 17.45, incisi quei segni per incollare del legno alle onde, sulla vernice che si trovava in superficie la colla vinilica non prendeva. L’escavazione non fu dettata da motivi estetici o concettuali, un solo motivo pratico era, di esse incisioni, alla base. Tutto l’iter, e le sue diramazioni (legnose-verdi-secche, in piedi e cadute, integre e tagliate, fronzute e spogliate, nude e vestite) ha avuto origine da un contatto in alcun modo compatibile – ci pensava la centrifuga del frantoio a separare cremoso e profumato verde da marrone acqua opaca, in che percentuale uno? in che percentuale l’altra? quanto pesa uno? quanto è pesante l’altra? Non importa quanto è importante uno ossia quant’è importante l’altra: è ciò che importa a noi che scriviamo, e dipingiamo, e suoniamo, scriviamo la musica e ne sentiamo il suono che non c’è, parliamo di pittura che, pur non essendoci ancora, vediamo. Non si tratta di magia, la nostra testa è siffatta. ZaraSostra con tale spalla cantò.
La realtà è questa, è apparenza; e rughe di uno specchio che s’incurva con parsimonia – lo specchio modula e assorbe l’invecchiamento; il succulento archivio di ricordi e tempo incamerato viene rispedito a scaglioni, a singhiozzo, il singozzo sbatte la porta: il ritratto è fratto, tratta bene la degnitosa firma, maltratta la rimessa a palla; lo specchio la sua età rallenta, guardando, negli altrui manifesti anni adagio sibilati, i timpani e i venti acchiocciolati; bisogna imparare dallo specchio, esso si risparmia, bisogna imparare a non tenerne conto del sé riflesso, come fosse acqua che scorre, riappare, in tutte le immagini in fuga nell’andante e mosso brillio che tra i vortici tiene in riga – quindi, strano a dirsi, anch’egli invecchia, lo specchio, senza storture e punture di visi ingolfati, ostruiti, soffocanti a vedersi, per tumefatto contagio. Riempitivi gonfiaggi, ad essi un secco no, due asciutte rughe, una e due; e, dopo, le altre, le tante di un volto vissuto che non è da innominabile serie; u busciularo, forse con una alimentazione corretta riesci ad evitarlo, o a ridurlo. Uno specchio di latta come i tamburi, di legno come i violini, di ottone come le trombe, in piedi come le arpe, seduti come i pianoforti, speculari come i piatti che l’immagine schiacciano, il vetro spezzano, l’argento disperdono: un colpo e l’attesa va in frantumi, cola il suono, rimbomba u tronu, vibra l’aria scura di una sala da concerto fattasi vuota nel respiro assente: tra discoli grani di coscienza in polvere, è riflettente; c’è uno specchio assopito nella sala, da lì arrivano i suoni di una pagina vestita a puntino, due pagine, tre pagine, quattro pagine staccate, da una parte Strauss, dall’altra Strega. Strix, voli e canti di civette e gufi, ora posso dormire. Maledetti Sprenger e Kramer! Datemi il martello di Nietzsche, voglio darlo in testa a due criminali macchiati di orrendi fatti, ripetuti, ripetuti. Incoraggiati, resi acuti, cronici da bianchi fautori, criminali anch’essi. La depravazione al di là – l’unico aldilà – dell’immaginabile in duemila anni di storie cupe, assassini, avvelenamenti, compravendita di corpi morti e vivi, sofferenza inflitta per predisposizione e gusto. Indulgenze. Infallibilità.
“D’un tratto mi sono reso conto che il cocchiere stava tirando le briglie e fermando i cavalli nel cortile di un grande castello diroccato, dalle cui alte scure finestre non veniva raggio di luce. Merlature infrante si disegnavano frastagliate contro il cielo illuminato dalla luna.” “All’improvviso mi resi conto che il cocchiere frenava i cavalli e si fermava nel cortile di un grande castello diroccato, dalle cui nere finestre non usciva neanche un raggio di luce. Le mura sconnesse si stagliavano come una linea interrotta contro il cielo di nuovo illuminato dalla luna.” Egli: il non-riflesso. Capitolo I, pag. 13; capitolo primo, pag. 31. Opere citate in altro tempo. Sostla-Stlauss.
9.3.19, ore 15.40. Primi disegni su due delle nove onde stese ad asciugare di dieci anni fa, lascerò l’occhiello a vite che allora mi servì per appenderle. Agganciandole ad un filo teso tra due piloni di ferro, diedi ad esse nome e futuro: onde sospese in quel luogo che tale azione accoglieva, e nel quale la stessa azione avrebbe avuto il tempo di svolgersi, quindici giorni e ancora quindici di proroga; le onde avrebbero perso liquidità, sarebbero evaporate. Un decennio dopo non sono ancora asciutte, azzurre erano e azzurro acqua sono rimaste, uguali e inalterate le ho trovate; in una pellicola di polvere, questo sì, penso sia stato giusto questo velo a preservarne l’umidità di superficie, le ho catturate, umidità e polvere, passandovi sopra la mano, ne è nato un suono nenufero, solo in quel breve contatto, per poi inabissarsi in vacillanti circoli e lenta, progressiva, pacifica, tranquilla, silente oscurità, lontana, intuibile, eterna spugna di progetti visti, immaginati, e suoni sentiti, appresi, mai scordati. Mi aspettano gli altri sette, dopodiché continuerò con silhouette nere, lucide, su carta nera, ruvida opaca.
Non so se in questo senso – nella carica a testa bassa – i miei anni li guiderò, mentre altri, impostori, nel tempo abbondante di cui, sprecandolo senza ritegno alcuno, possono disporre, tentano di dare disciplina ai sogni – mi veni vogghia di pigghiarli a scuppuluna –, come se i sogni si potessero guidare verso ottimismo e bontà, a modo loro (sempre di quei funesti tipi) intesi.
Basta girare la luna, sciogghila! Scioglila, comu si ’nte manu avissi na strummula, dal cotone rosso carminale che la copre per metà, la sua punta tutta.
Sì, Bonnard è un’altra cosa; scorrimento, avvicendarsi di notte e giorno, la notte, difatti, non c’è. “Alternarsi” in simultaneità, più che nei passaggi futuristi, di interno ed esterno, prima e dopo e tempo fermo. Ma, le linee tremule di Pierre e il tempo frigge, le pietre non sono pietre e tutta la materia è viva, “ok”, è semovente; e il caldo fermenta di miraggi e di cicale, di piatti, tavoli, tovaglioli e sedie. È tutt’un mondo di colori che nell’aria gira. Ti senti agghiummuliato di benessere. Starnuto e polline, denti di sopra e denti di sotto. L’acqua del mare il vento pela; scrocchia il grido crudo delle onde, il cielo si copre e avanza di fretta, occorre ritirarsi, l’urlo del sale per spirali affonda, e il fondo del mare è fatto di onde che una sull’altra si sono insieme acquietate, le corde vocali ritorte, zittite su due scalini di un foglio. Strauss. St! Sst! Con la mano destra piatta che lenta si muove, ora il suono deve sfumare sino al silenzio; spegni la luce, dai il la al sonno, dormi, accendi i sogni; dormo e son desto, firmo ali di olio di lino. Ora rompe il silenzio in un nuovo uso di parte di una parola già esistente, passabile, “così” da farne ad alta voce un’altra.
10.3.19, stessa ora di ieri: Disegno Terzo, Disegno Quarto. Che bel nome, Disegno, anni voce, anni luce dista dal terzo di Segni e dal di Segni nono, Innocenzo Gregorio Lotario Ugolino. 4004, 2-1. Tavola quinta, non ho segnato la data. Pomeriggio del 23.3, tavola sei, sulla minore, in altezza, delle onde finora utilizzate.
Oggi, 25 marzo, ore 17,25, disegno settimo, il violino e l’archetto. La prima volta del pastello bianco, ore 17,32; forse lo userò anche sugli appaiati e addossati in attesa. Quella settimana a Milano, dall’undici al diciassette, una sera, di ritorno dal centro verso la stazione, conferenza da ospizio, un tipo che credeva di aver scoperto il vero volto di Leonardo, le sue stesse parole contraddicevano le immagini che mostrava, le immagini che mostrava contraddicevano le parole – ossequiose su ogni tipo di autorità – che diceva; quand’anche fosse vero, ma chi se ne importa! Una sera, di molti anni fa, in quello stesso luogo, mi capitò, durante un concerto per pianoforte e voce, di stare spalla a spalla con la signora Busoni nel ritratto di Boccioni, appeso dietro di me e totalmente sguarnito di protezione. Penombra e suono fissarono questo ricordo, e il silenzio della Busoni con la bocca tappata da strette pennellate parallele. È un bel quadro, degno degli anni migliori del cubismo “policromo”.
27.3, le onde sono dieci, ore 16.50. Le avevo contate male.
Stessa data, ore 17.30, fagotto. Quale strumento alla decima? Deciderò a suo tempo; cioè a breve, nel giro di qualche giorno, forse domani.
Ore 18.37, primo disegno su carta nera-violacea di cm 21x14,7; è un flicorno?
28 marzo (oggi lettere), si tratta di un flicorno basso con tre (pure per quest’altro numero) pistoni. L’onda prima dell’ultima avrà un piano (quando cammina) forte (se riùggisce) del diciannovesimo secolo a coda sviluppata in verticale. Sic! Così spariscono le glorie dell’oltremondo!
Non-di meno.
Sostra
www.sicula.com feliscatus@sicula.com
- letto 1090 volte